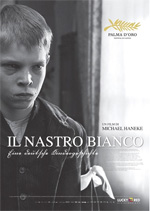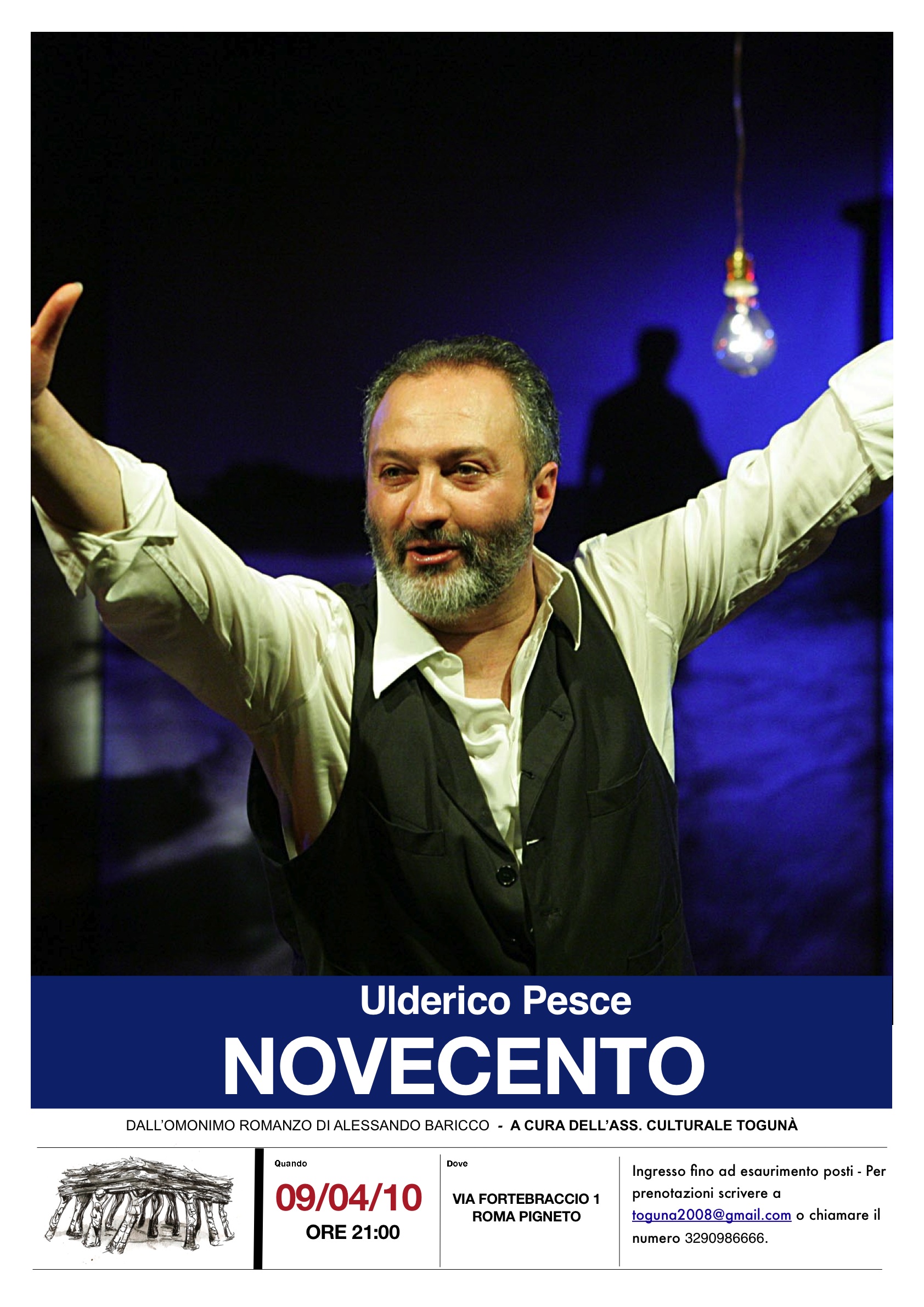Si è trattato di un mutamento silenzioso, avvenuto intorno al 2007, un punto nella storia: più della metà della popolazione abita attualmente le città. Dalle città mesopotamiche del IV millennio prima della nostra era alle megalopoli raggruppanti decine di milioni di abitanti, il processo di urbanizzazione è stato intermittente. Ma sempre connesso alla divisione del lavoro e alla formazione delle classi, con la concentrazione di potere e di saperi. L’attuale civilizzazione urbana nasce con la rivoluzione industriale, ereditandone le dualità. Nella città, dove la segregazione sociale emargina i poveri, tra le città, poiché allo sviluppo verticale di tecnopoli avveniristiche si accompagna la crescita orizzontale delle bidonvilles. Centri urbani pensati come centri di profitto, le metropoli si affrontano per intercettare i flussi di capitali, di merci e di popolazioni benestanti. Facendo gonfiare bolle immobiliari e collera popolare.
Le capitali del capitale
di Jean-Pierre Garnier*
Da Bombay a Pechino, passando per Londra, New York e Parigi, la ristrutturazione urbana attraverso la “distruzione creatrice” ha assunto una dimensione planetaria. Qartieri popolari ben collocati vengono riassettati e i loro originari residenti spediti nelle periferie, in alloggi di basso livello per fare spazio ad abitanti di lusso, sedi sociali, istallazioni culturali prestigiose capaci di attirare investitori, immobiliaristi, direttori di società, quadri superiori e turisti abbienti.
In breve “la bidonville globale entra in collisione con il cantiere di costruzione globale – afferma il geografo David Harvey – e tale atroce asimmetria va interpretata come una forma evidente di confronto di classe (1)”
Bisogna dedurre quindi che, al di là dell’apparizione di nuovi processi di ristrutturazione urbana e architettonica, la lotta secolare tra dominanti e dominati per la conquista (o la riconquista) dello spazio urbano prosegue secondo una dinamica immutabile?